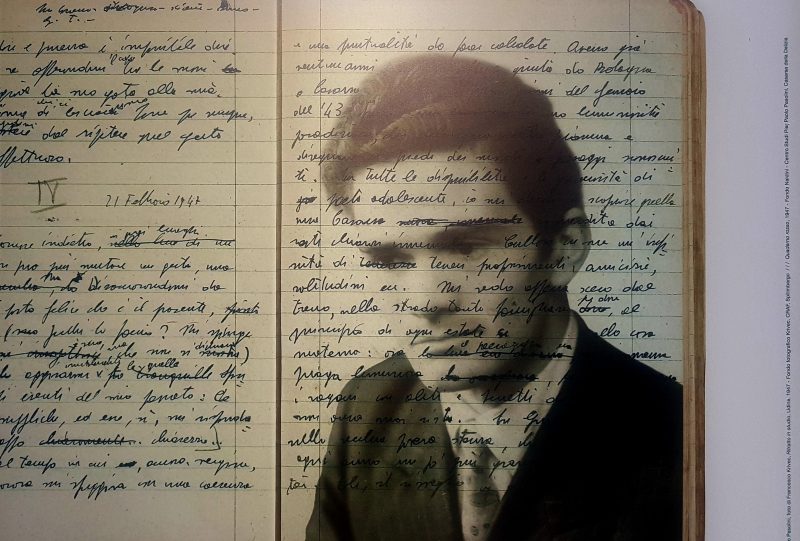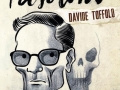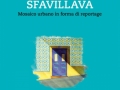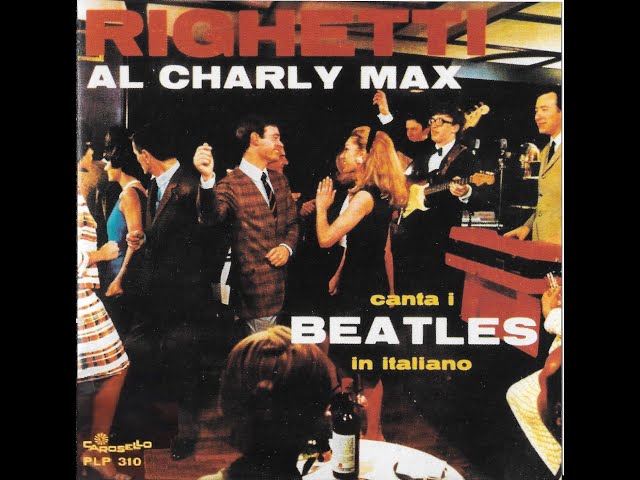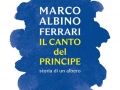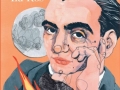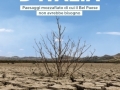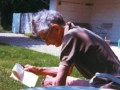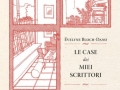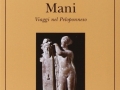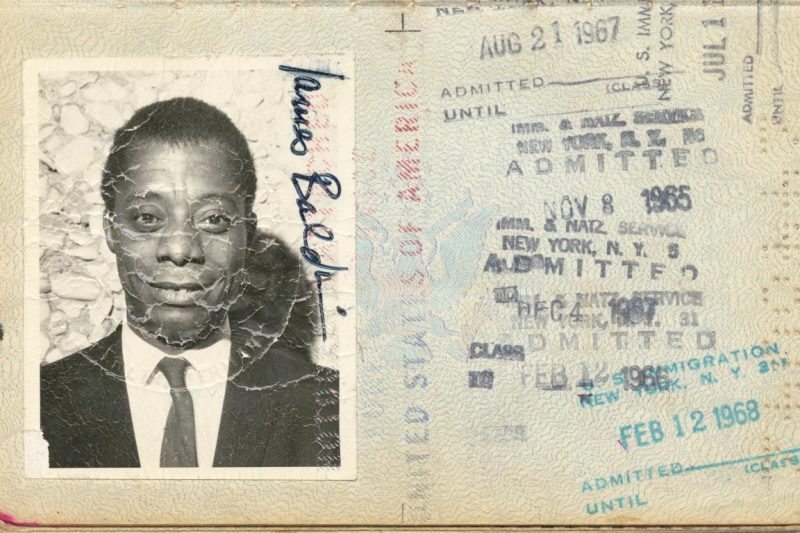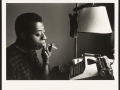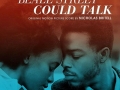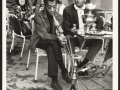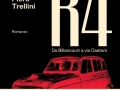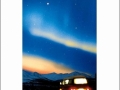L’Andarocco, una crasi tra Andalusia e Marocco, sarà la meta del viaggio con gli ascoltatori della radio dal primo al 10 aprile.
Granada. Il passato andaluso e il mondo di Federico Garcia Lorca. Il Sacromonte, il quartiere gitano famoso per le sue case-grotte scavate nella roccia. Oggi le più famose sono la Cueva de María la Canastera o la Cueva de La Rocío. Entrambe sono dedicate alle zambras, un’ibridazione tra la danza del ventre e il ballo flamenco. Un mix tra la cultura gitana, con le vestigia della cultura musulmana, in una sorta di matrimonio gitano rappresentato, senza tablao, né palco, in cerchio, molto vicino allo spettatore. Il tutto dentro grotte bianche e spaziose, ornate da vasi di rame lucente.
Ci sarà anche il tempo per una birretta in Placeta Joe Strummer, ascoltando assieme una canzone dei Clash. Strummer conosceva bene Granada, non solo per averla menzionata nel brano Spanish Bombs (da London Calling), ma anche per aver cominciato a frequentarla dal 1983, dopo l’uscita del chitarrista Mick Jones dai Clash. In quel periodo, Strummer si trovava in città per produrre l’album della band spagnola 091, che aveva conosciuto in uno squat a Londra.
Marinaleda. Un paesino dell’Andalusia nella provincia di Siviglia, baciato dal sole come molti altri affascinanti pueblos blancos del sud della Spagna. La sua specificità è la storia socio-politica che l’ha trasformata in una piccola enclave socialista andalusa. Tutto inizia nel 1979 con il sindaco Juan Manuel Sanchez Gordillo, a capo del movimento Izquierda Unida. Un sistema economico basato sull’eguaglianza e sulla condivisione di risorse. L’esproprio della terra ai latifondisti, trasformata in bene comune. L’edilizia popolare (affitto della casa a 15 Euro) e l’esperienza della domenica roha. Quota mensile dell’asilo nido comunale: 12 euro a bambino, inclusi pranzo e colazione…
Siviglia. La città d’Europa con il maggior numero di strade dedicate alla Madonna: 48 tra vie e piazze. Ma nell’Alcazar ha eretto un monumento a un monarca musulmano di tanto tempo fa, la cui stele recita: “La città al suo re Almutamid Ibn Abbad. 900 anni dopo”. Un’attenzione per la propria storia che induce Siviglia a conservare gelosamente antichi colori e profumi: il giallo e il blu delle maioliche, il bianco accecante delle case andaluse, le scie di arancio e di incenso che da giardini e cattedrali si spandono su strade e piazze, come in tutti i paesi in cui si prega molto e si pecca di più. Il peccato di gola più reiterato è legato alla liturgia delle tapas: una transumanza che porta i sevillani da un bar all’altro, consumando piccoli spuntini accompagnati da un bicchiere di vino o da una cervesita. Un rito che annovera più fedeli di quelli delle processioni della Settimana Santa… Gli indirizzi ‘segreti’ per i fondamentalisti del flamenco nuevo e La Carboneria, ex deposito di carbone, oggi luogo per jam session flamenche.
Tangeri. “Quando (il vento) arriva a Tangeri si mette a girare in tondo e non sa più da che parte andarsene”. Sono parole di Tahar Ben Jelloun in “Giorno di silenzio a Tangeri”. Ed è proprio il vento la prima presenza tattile in cui ci si imbatte entrando nella Città Bianca. Le folate del chergui, il vento dell’est, veicolano anche le note delle mille musiche che in questo lembo di terra, che non è più Europa e non è ancora Africa, hanno avuto i natali. Musiche che hanno la capacità di essere moderne e nel contempo evocatrici di un lontano passato. Una dicotomia che vive ovunque nella città e che si respira nel suq, in particolare il giovedì e la domenica, quando dalle montagne scendono le contadine per cercare di vendere le proprie mercanzie…
Qui le info per il viaggio: https://www.viaggiemiraggi.org/viaggio/viaggio-in-spagna-e-marocco-traversata-arabo-andalusa-con-radio-popolare/