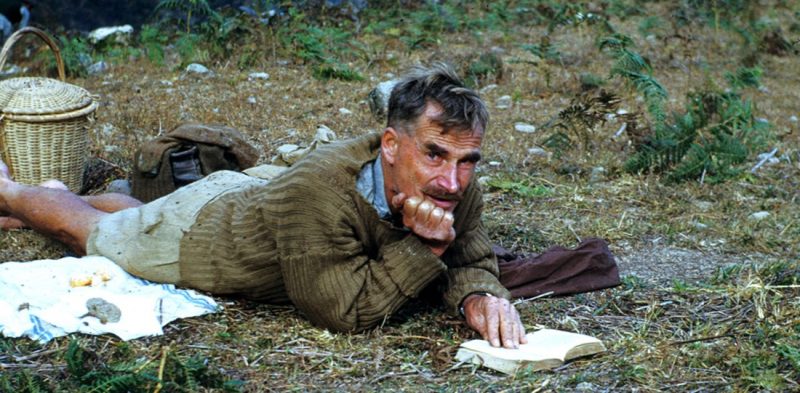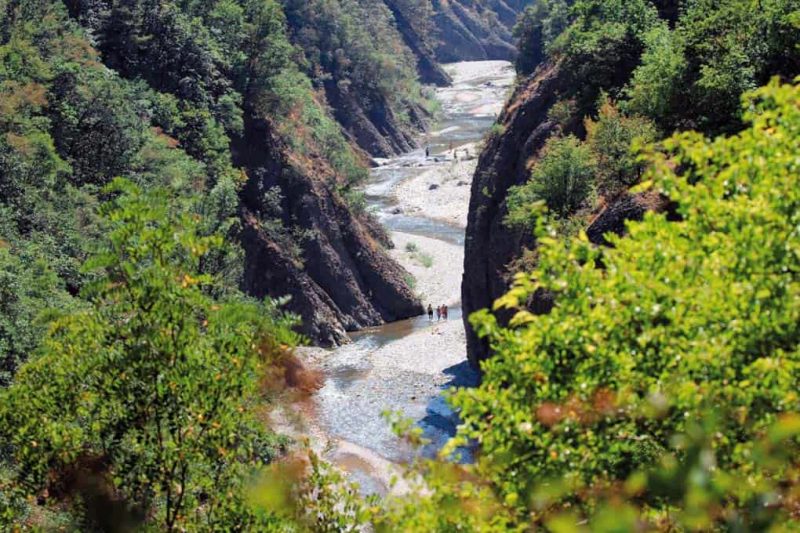Prima di visitare Parigi bisogna arrivarci. Finalmente si può tornare a farlo in treno, a bordo del mitico TGV. L’ha sperimentato per noi Giulia Strippoli che durante il viaggio ha chiacchierato con Pamela Aiuolo di SNCF Voyage Italia, che racconta le specificità di questo viaggio. Un viaggio che, oltre a regalare buoni sconto per musei e ristoranti parigini, è uno dei modi di viaggiare più ecologicamente sostenibili.
A proposito di soste va ricordato che la capitale francese è la città che più sta sperimentando tecniche green di sopravvivenza urbana in tempi di crisi climatica. Un esempio da imitare è quanto fatto, agli inizi del 2020, a Porte de Montreuil, nella cintura orientale di Parigi. Lavori che oggi le permettono di essere diventato un quartiere a emissione zero.
Veronica Gennari, una delle nostre corrispondenti da Parigi, ci ricorda di non andare al Centre Pompidou che è chiuso sino al 2030 per lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Veronica però ci ricorda dove saranno ‘parcheggiate’ molte sue opere in modo che possano essere visitate in questi 5 anni.
Utilizzando come guida il libro di Flavia Capitani “A Parigi con Serge Gainsbourg. Sulle strade della rivoluzione con Jane Birkin”, un prezioso volumetto che fa parte di una ricca collana di Giulio Perrone editore che esplora luoghi e città seguendo vita e opere dei grandi artisti della storia, si possono ripercorre alcune geografie del celeberrimo ‘cantautore maledetto’ e della sua musa. Si può partire da Lilas, “a est della città, un po’ fuori dai venti arrondissements” scrive Flavia Capitani “perché quella zona ha ispirato il suo primo successo, Le poinçonneur des Lilas, pubblicato nel 1958”. Ed arrivare sino alla Maison Gainsbourg, una meta con due indirizzi: il leggendario interno al numero 5 bis di rue de Verneuil; e dall’altro lato della strada, al civico 14, un museo, una libreria-boutique e un café piano-bar chiamato Gainsbarre.
Marzia Fiorito, storica dell’arte, ci ricorda che Parigi è donna. Per sincerarsene consiglia una visita al Pantheon per visitare gli spazi dedicati a sette donne che hanno fatto la storia (tra queste Maria Skłodowska Curie ). Troppo poche (e con gravi ritardi) rispetto agli 82 uomini pantheonizzati…
Veronica Gennari chiude la puntata ricordandoci alcuni locali dove andare ad ascoltare ottima musica. Oltre al Bataclan , che a 10 anni dalla strage del 13 novembre 2015, continua ad ospitare concerti prevalentemente di rock e punk, Veronica segnala, per chi è interessato a scoprire giovani artisti francesi, La Maroquinerie nel XX° arrondissement.
www.franceguide.com info.it@franceguide.com
[ngg_images source=”galleries” container_ids=”332″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]