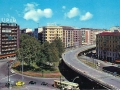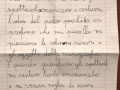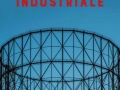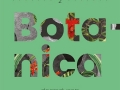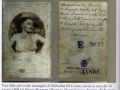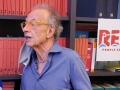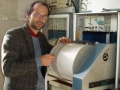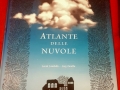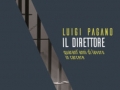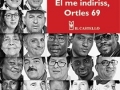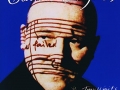L’oasi di Sant’Alessio è un parco che consente, senza infastidire popolazioni di animali selvatici, di entrare in contatto ravvicinato con loro e con l’habitat naturale in cui vivono. Un habitat ricreato con cura e passione qualche decennio fa quando Antonia e Harry Salamon acquistarono il castello di Sant’Alessio, per anni casa di caccia dei nobili Beccaria, e il campo di erba medica che gli stava intorno. E’ un ottimo viatico per poi inoltrarsi in una micro-regione, l’Oltrepò pavese, che merita di essere conosciuto, oltre che per salumi e vini, anche per le sue farfalle. L’area naturalistica di Valverde dista una cinquantina di chilometri dall’Oasi di Sant’Alessio. Siamo all’interno di un parco di oltre trecento ettari che ospita il Sentiero delle Farfalle, ricavato grazie al mantenimento di aree erbose aperte e alla messa a dimora di piante nutrici dei bruchi e di piante nettarine o aromatiche, ideali per l’habitat dei lepidotteri adulti. “Qui non è mai stato fatto nessun rilascio, vivono solo farfalle selvatiche” ci dice Francesco Gatti, naturalista e butterflywatcher, presidente dell’associazione IOLAS * . Altre due mete sono le rupi ofiolitiche di Pietra Corva e Pan Perduto, nel comune di Romagnese, e le praterie del Monte Alpe, a Brallo di Pregola. Distano tra loro una ventina di chilometri, ma sono morfologicamente molto più distanti. La prima meta offre affioramenti rocciosi, accompagnati ad aride praterie poco estese che hanno una flora (e quindi una fauna di lepidotteri) tipica. La seconda, ricca di boschi, nei pendii e sulle aree sommitali presenta prati e pascoli particolarmente interessanti per il butterflywatching. “Visitando queste due aree” ci confessa Francesco Gatti “in un sola giornata si può arrivare ad avvistare una settantina di specie di farfalle, ovvero più di quelle che un britannico può vedere in tutta la sua vita restando in Inghilterra”. All’imbrunire si può fare tappa nella vicina Zavattarello, un borgo medievale in Alta Val Tidone dominato dal Castello Dal Verme. Qui, presso il Bioagriturismo Olistico Valtidone Verde , è possibile regalarsi una sessione di kinesologia, una disciplina che si basa su concetti di medicina tradizionale cinese, e assaggiare alcuni ‘frutti antichi’ che l’agriturismo coltiva per preservare la biodiversità. Come suggerito da Riccardo Starnotti , esperto dantista che organizza escursioni lungo le rotte percorse dal Sommo Poeta nel Casentino, la giornata può chiudersi leggendo
i versi che Dante Alighieri ha dedicato alle farfalle nel X° canto del Purgatorio…
* IOLAS (Associazione Pavese per lo studio e la conservazione delle Farfalle)
Fondata nel 2015, affronta la sua mission – conoscere e conservare la natura – ispirandosi ai principi e agli scopi della citizen science, tra cui la promozione sociale. Cura i pannelli esplicativi, recanti testi e immagini, che “guidano” i visitatori nelle loro escursioni alla scoperta delle popolazioni di farfalle che abitano l’Oltrepò (percorsi realizzati nell’ambito del progetto AttivAree – Oltrepò (bio)diverso – la natura che accoglie, finanziato dalla Fondazione Cariplo).