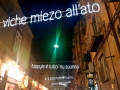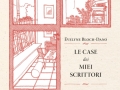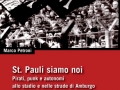A Napoli per capire quanto si è popolari basta andare in San Gregorio Armeno, la via dove decine di artigiani vendono le statuine del celebre presepio partenopeo. Un presepio dove oltre alle classiche statuine con il bue, l’asinello e i re magi ci sono quelle dei personaggi della cronaca e della politica. E’ una sorta di classifica partenopea dei personaggi più pop degli ultimi mesi. Quest’anno le statuine laiche che vanno per la maggiore, sono quelle di De Luca, il presidente della regione Campania ritratto con in mano un lanciafiamme; quelle di Alex Zanardi che pedala sul suo handbike e quelle di Liberato, rappresentato di spalle con la felpa con il suo nome sulla schiena. Liberato è un cantante mascherato di cui non si conosce l’identità: una sorta di Elena Ferrante del pentagramma. La sua musica è un incrocio tra elettronica, trap e afrori neomelodici. Leggendo le sue liriche è sorprendente scoprire analogie con il testo di Carmela, un classico della canzone napoletana. Se è vero che l’amore è il contrario della morte, come recita la canzone di Salvatore Palomba, è a quello che la città deve aggrapparsi per tornare a vivere: all’amore della sua gente, non alla morte sociale voluta da pochi. Oggi per sentire canzoni come Carmela bisogna andare al Trianon Viviani, sede della compagnia stabile della canzone napoletana. In cartellone un repertorio di classici, tra cui qualche canzone scritta al Gran Caffè Gambrinus, il caffè letterario più prestigioso della città. Qui abbiamo incontrato Arturo Sergio, uno dei proprietari. All’hotel Luna Rossa invece abbiamo incontrato Adele Mazzella, nipote di Antonio Viscione, in arte Vian (nick name adottato per omaggiare il grande scrittore e trombettista francese Boris Vian). E’ lui il compositore della canzone che dato il nome all’hotel, una canzone che è stata reinterpretata da decine di artisti: da Claudio Villa a Jovanotti, da Frank Sinatra a Caetano Veloso. C’è un altro albergo che ha contribuito a scrivere la storia della musica napoletana. E’ su una punta della Penisola Sorrentina, “…lì dove il mare luccica e tira forte il vento…”. La “vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento” che Lucio Dalla rese immortale attraverso le note di “Caruso”esiste davvero: è la balconata più celebre della musica italiana (sulla quale fu realmente composto il brano) e appartiene alla suite del Grand Hotel Excelsior Vittoria, un cinque stelle sicuramente accessibile a pochi, ma che condivide con Napoli un’importante pezzo di storia della cultura e della musica italiana. Dalla stazione ferroviaria di Napoli bastano quindici minuti di taxi per raggiungere San Pietro a Patierno, il borgo dell’immediato hinterland napoletano dove è nato Nino D’angelo. Sulla parete di un anonimo palazzone lo street artist Jorit ha appena terminato di realizzare un enorme ritratto del padre putativo della musica neomelodica. La novità dei neomelodici, all’interno della musica partenopea, è la loro provenienza: è tutta gente dei quartieri popolari, come San Pietro a Patierno. Per i testi delle canzoni prendono spunto dalla vita e dai sogni di chi in quei quartieri vive. Canzoni che diventano subito le colonne sonore dei loro momenti di festa, dai battesimi ai matrimoni. A Scampia, altra periferia napoletana, incontriamo e ne parliamo con Daniele Sanzone, scrittore, autore e voce della rock band A67.
Altre puntate di Onde Road su Napoli sono qui:
– La Napoli del Rione Sanità blogs.radiopopolare.it/onderoad/?p=4486
– La Napoli dei Maestri di Strada e del dios umano blogs.radiopopolare.it/onderoad/?p=4322
– Una Napoli altra blogs.radiopopolare.it/onderoad/?p=3356