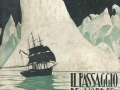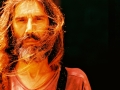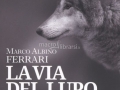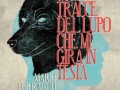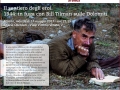Il viaggio nel nord dell’Iran è un viaggio dentro mondi diversi, che susseguono, uno dietro l’altro. Mashad, città sacra agli sciiti in quanto sede del mausoleo dell’Imam Reza, ottavo imam degli sciiti e discendente del Profeta, martirizzato nel 817. E’ la prima città santa dell’Iran e tappa obbligata del pellegrinaggio religioso. Una delle meraviglie del mondo islamico. La strada che, costeggiando le montagne delle mille moschee (le Dolomiti iraniane), porta, nelle adiacenze del confine con il Turkmenistan, sino a Kalat: un villaggio, piazzato su un vasto massiccio protetto dalle montagne, che ha saputo resistere all’assedio di Tamerlano. La tomba di Ferdowsi, il maggior poeta epico della letteratura persiana medievale. Il fascino senza tempo della Torre astronomica di Radkan, costruita alla fine del 1200, dove si può calcolare il primo giorno di tutte le stagioni (equinozi e solstizi), gli anni bisestili e si può calcolare il mezzogiorno in tutte le giornate di sole. Se si guardano le stelle sulla parte superiore della torre di Radkan si possono inoltre trovare le latitudini e l’azimut delle stelle, come con un telescopio. Il coraggio di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali appena rientrati in Iran dopo anni di emigrazione in Occidente, che a Radkan hanno ristrutturato una vecchia casa tradizionale, con più di 100 anni di storia, trasformandola in un eco resort (www.radkanarg.ir) dove è possibile mangiare e dormire. Le barche che solcano il Mar Caspio per raggiungere Bandar-e Torkeman, nella regione del Golestan. L’incontro a Gorgan con una donna che gestisce la “Gorgan Women’s Charity Association“, una struttura che tra le sue mission ha la valorizzazione e l’accrescimento dell’autostima delle persone disagiate, in particolare delle donne capofamiglia. La magia di Masuleh, un villaggio a mille metri di altitudine con un’architettura unica, l’unico luogo totalmente pedonalizzato dell’intero Iran. Aggrappato al fianco della catena montuosa di Alborz, lungo un dislivello di circa cento metri, presenta una conformazione terrazzata in cui il tetto della casa inferiore costituisce il cortile e il marciapiede di quella superiore. Un eccellente esempio di ecosostenibilità sia per i materiali usati (le case sono in legno e argilla su due piani collegati da scale tortuose) che per i labirintici passaggi che collegano i vari strati cittadini che rendono impossibile l’accesso delle auto. L’ascesa alla fortezza di Alamut: situata a 1800 metri, nel cuore dei Monti Elburz, è famosa per essere stata il nucleo della cosiddetta “setta degli assassini”. Una setta tristemente famosa per la sistematica eliminazione fisica dei rivali politici e in generale dei nemici dell’Islam. Gli adepti venivano imbottiti di hashish (il nome “assassini” sembrerebbe proprio coincidere con l’arabo “consumatori di hashish”) in modo da essere suggestionati al punto di compiere missioni a priori ritenute suicide.
Anche le immagini di un viaggio come questo hanno qualcosa di lisergico, ma per viverle non c’è bisogno di fumare niente di strano…
Ascolta il podcast: